
|
La poesia romanesca è ricca di briose descrizioni popolari |
|
La tombola di Natale
rallegra "casa nostra"
 A
Natale, il pranzo era una vera e propria kermesse gastronomica,
iniziata con il tradizionale brodo di cappone con i cappelletti e
proseguita con una ricca lista di portate che davano vita a un
animato e tradizionale folklore domestico, facendo puntualmente
onore all’antico detto: "A
quel che spendi oggi non badare - Solo una volta l’anno vien
Natale".
Giunto
il momento di sparecchiare la tavola, in rumorosa e gioconda
baraonda si prendeva di nuovo posto per giocare a tombola con grande
gioia dei più piccoli che speravano in portentose vincite, ma con
visibile noia dei più anziani che, appesantiti dalle pantagrueliche
libagioni, avrebbero preferito fare in santa pace una ristoratrice
"pennichella". Alla fine, le insistenze dei giovani vincevano la
ritrosia dei vecchi che finivano per accondiscendere al loro
prepotente richiamo.
I poeti
dialettali hanno raccontato con i loro versi la festosa usanza della
tombola natalizia, tanto che la letteratura romanesca ne fornisce
numerosi esempi, ricchi di verve popolare.
Ecco
come Antonio Ilardi racconta con un sonetto una tombola del 1883 in
cui emerge tutta una nomenclatura popolare relativa all’estrazione
dei numeri, ancor oggi in voga, seppur in minima parte: "- ‘Mbè je
la famo?... Tiro?... sete pronte? / - Aspetta, famme mette armeno a
sede... / - Tira piano... - Che sete sorde e tonte? / - Da sta parte
nemmanco ce se vede! / - Fatte imprestà l’occhiali dar Curato! / -
Stateve zitto là... perdete er fiato. / Magara tutto!... - E daje?...
— Purcinella (75)
/ La Purce (38), li Pollastri (27),
er sor Ninetto (1),
/ Moneta(26), Madre (52), Pena (51), Carettella (22),
/ Bacio (2),
la Caponera (14),
er Diavoletto (13),
/ Er Prete (28),
er Fiume (81),
avò, Papa Leone (58),
/ Zero er più vecchio (90),
er Gatto (3), un
bel Lampione (10)
/ - E’ uscito er venticinque?... — Sta in padella! / - Statece
attenta... - Che ‘n se po’ arisponne? / - Tavola
apparecchiata (44), la Barella (16),
/ Li Pidocchi (37), le Gamme
delle Donne (77), /
Er Frate (43),
li Palloni (88),
la Lanterna (54)...
/ - Abbasta!!! sì
‘umme sbajo è la quaterna. / - Che culo! — Cuminciamo a uprì er
soffietto? / - State zitte, nun fate confusione. / - Che te fa
tazza? magnete l’aietto. / - Si seguita accusi fo’ napulione. / -
Tiro?... Er Natale
(25)... — Mette,
Crementina... / - Basta! colla medesima: cinquina! / - Daje! ... -
Scànnete - è escito
er trentanove? / - Sta a mollo che s’asciutta! — Gallinaccio
(6), / Fratello (89)
- Sta defora er dicinnove? / - Vierrà! - Cortello (41), Foco (8), Campanaccio (9),
/ La Pulitica sporca (39), Imbriacone (19)
/ - Tommola! - Je s’è aperto er chiccherone. / - Reggistra sì
ciammanca quarche palla... / - Hai voja a baccajane, mò è finito...
/ - L’ha contate du’ vorte Rosa e Lalla / - Ma conta. — Va a
contalle a tu marito. / - Storcete puro er collo faccia bella... / -
E’ pagabile a vista... la cartella!"
Pietro
Gibertoni, poeta vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi del
Novecento, dà una sua gustosa interpretazione di una "Partita a
tombola", appena terminato il pranzo di Natale: "- Allora cominciate
a perde’ er fiato! - / Trentuno, trenta, tretatré — E smucina!- /
Cinquanta e sessantuno rivortato, / trentotto — E daje giù co’ sta
trentina! / - Dieci, pulenta, ventisei Pilato... / - Tireme er
ventinove, Teresina! - / - Ecchelo er ventinove - L’ha chiamato! - /
- Davero? Allora, ecchela qua: cinquina! - - / Sta fermo co’ le
mano. - Sei, pangiallo. - / - Ma de chi so’ sti piedi. E’ ‘na
disdetta, / è ‘n’ora che me stanno a pistà un callo! - / Pietruccio,
tonto già dar vino e er sonno / se sbaja co’ li piedi de Ninetta / e
pista invece quelli de su nonno!".
Anche
se oggi le usanze appaiono alterate e nonostante che i romani non
abbiano più lo stomaco "foderato de bandone" come i progenitori
dell’Ottocento, non pochi, seppur con maggiore attenzione, si
lasciano sfuggire l’occasione di rimanere fedeli al pranzo di
Natale, secondo le usanze gastronomiche "de casa nostra". Non
ultimo, sopravvive il rito della tombola che ancor oggi si presta a
momenti di allegria e a battute spiritose.
di Antonio
Venditti |
|
I giochi di ieri
rivivono oggi |
|
I Saturnalia, un’antica
tradizione
“in tavola” a dicembre
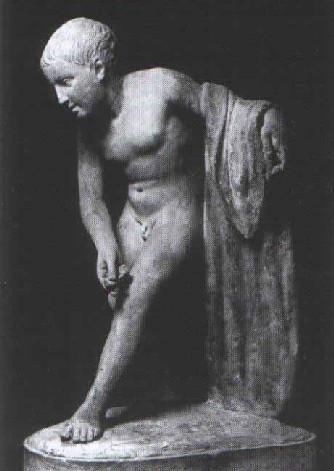 Tempo
di Natale, tempo di giochi. Sarà lo spirito conviviale che anima i
giorni di festa, sarà il piacere di trovarsi intorno ad un tavolo a
tentare in compagnia la sorte, fatto sta che dicembre è, tra tutti i
mesi, quello per eccellenza dedicato al gioco in famiglia. Una
tradizione antichissima che dobbiamo far risalire al tempo dei
nostri progenitori, quando a Roma, onorando il dio Saturno, si
festeggiavano i Saturnalia. All’epoca dell’imperatore Domiziano
(68-94 d.C.) le celebrazioni duravano sette giorni, dal 17 al 23
dicembre. In questo periodo, proprio come a Natale, si scambiavano
doni bene auguranti ed il popolo, gioioso, si aggirava per le strade
gridando: “Io Saturnalia, bona Saturnalia!”, una formula molto
simile al nostro “buon anno”. Per l’occasione le scuole ed i
tribunali rimanevano chiusi, i militari ottenevano le licenze e, in
via del tutto eccezionale, gli schiavi potevano mangiare al tavolo
con i loro padroni. Tra le concessioni della festa, c’era anche
quella di permettere il gioco d’azzardo, proibito dalla legge negli
altri periodi dell’anno. Una misura precauzionale dello Stato:
intere fortune potevano essere mandate in rovina, tanto era diffuso
presso gli antichi il vizio del gioco! Scrive Marziale in un
epigramma: “abbandona un po’ l’austerità / ecco che Dicembre libero
dalle leggi / fa suonare qua e là gli incostanti bossoli / e giuoca
alla fossetta con l’astragalo sbarazzino”. Tempo
di Natale, tempo di giochi. Sarà lo spirito conviviale che anima i
giorni di festa, sarà il piacere di trovarsi intorno ad un tavolo a
tentare in compagnia la sorte, fatto sta che dicembre è, tra tutti i
mesi, quello per eccellenza dedicato al gioco in famiglia. Una
tradizione antichissima che dobbiamo far risalire al tempo dei
nostri progenitori, quando a Roma, onorando il dio Saturno, si
festeggiavano i Saturnalia. All’epoca dell’imperatore Domiziano
(68-94 d.C.) le celebrazioni duravano sette giorni, dal 17 al 23
dicembre. In questo periodo, proprio come a Natale, si scambiavano
doni bene auguranti ed il popolo, gioioso, si aggirava per le strade
gridando: “Io Saturnalia, bona Saturnalia!”, una formula molto
simile al nostro “buon anno”. Per l’occasione le scuole ed i
tribunali rimanevano chiusi, i militari ottenevano le licenze e, in
via del tutto eccezionale, gli schiavi potevano mangiare al tavolo
con i loro padroni. Tra le concessioni della festa, c’era anche
quella di permettere il gioco d’azzardo, proibito dalla legge negli
altri periodi dell’anno. Una misura precauzionale dello Stato:
intere fortune potevano essere mandate in rovina, tanto era diffuso
presso gli antichi il vizio del gioco! Scrive Marziale in un
epigramma: “abbandona un po’ l’austerità / ecco che Dicembre libero
dalle leggi / fa suonare qua e là gli incostanti bossoli / e giuoca
alla fossetta con l’astragalo sbarazzino”.
Capita aut
navia (il nostro “testa o croce”), gli astràgali (ossicini di
animali) lanciati sulle tabulae lusoriae, vere e proprie tavole da
gioco, o in fossette, i dadi (aleae, tesserae), la morra e diversi
tipi di “dame” con pedine erano i principali passatempi dei nostri
antenati. Durante gli altri periodi dell’anno occorreva trovare un
posto un po’ appartato per non dare troppo nell’occhio ed evitare le
pene dell’edile. Pare che persino l’imperatore Augusto, celebre per
la sua morigeratezza, fosse un accanito giocatore e, contravvenendo
alla legge, si concedesse questo svago fino in tarda età, anche nei
periodi dell’anno in cui non era consentito. Di poco si
accontentavano i bambini, il cui “patrimonio” poteva essere un bel
sacchetto di noci. La maggior parte dei loro giochi si basava
infatti su queste “biglie” facilmente reperibili. Potevano
divertirsi con le “nuces castellatae”, ossia cercando di lanciare
una noce su una base formata a terra da altre tre. Un’asse inclinata
costituiva una divertente variante: facendo rotolare sopra le noci,
si vincevano quelle che a terra venivano urtate. Il gioco del
“Delta” presupponeva maggiore abilità e consisteva nel centrare, da
una certa distanza, il punto più difficile del bersaglio, ossia il
vertice di un triangolo disegnato al suolo. La bravura dei piccoli
giocatori si poteva misurare anche lanciando le noci in un
recipiente dal collo molto stretto. Piccoli svaghi, a cui era più
facile dedicarsi nell’amato periodo delle vacanze.
di Annalisa
Venditti |
|