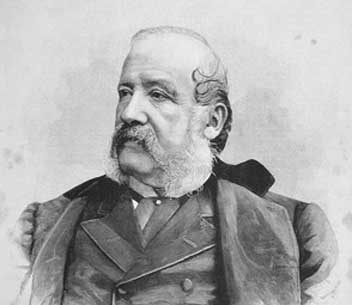 Gerolamo
Induno, fratello minore di Domenico, era nato a Milano il 13 dicembre 1825.
Aveva frequentato l’Accademia di Brera dove, dal 1839 al 1846, era stato allievo
di Luigi Sabatelli.
Gerolamo
Induno, fratello minore di Domenico, era nato a Milano il 13 dicembre 1825.
Aveva frequentato l’Accademia di Brera dove, dal 1839 al 1846, era stato allievo
di Luigi Sabatelli.
Fin dal 1845 aveva
esposto i suoi primi dipinti alla mostra braidense: studi dal vero, alcuni
ritratti e una Scena dai Promessi Sposi.
Dopo aver
partecipato ai moti antiaustriaci del 1848, si era rifugiato con il fratello ad
Astano, in Svizzera, quindi si trasferì a Firenze, dove si arruolò come
volontario sotto il comando del generale Giacomo Medici, con il quale, nel 1849,
partecipò alla difesa di Roma assediata dai francesi del generale Oudinot,
eseguendo molti schizzi e scene riprese dal vero.
Definito da
Garibaldi uno dei più "intrepidi e valorosi combattenti di Roma", Gerolamo
Induno fu impegnato nell’occupazione del Vascello. Il 22 giugno, per
ordine di Garibaldi, due compagnie del generale Medici tentarono da villa Spada
di impadronirsi della casa Barberini, all’interno di villa Sciarra, nel luogo
oggi intitolato al volontario belga Adolfo Leduq. I patrioti
riuscirono a penetrare nella casa, ma dovettero ritirarsi dopo una furiosa
mischia nel cortile e nell e
stanze. Durante quell’operazione, in cui perse la vita Giacomo Venezian,
Gerolamo Induno fu gravemente ferito da 27 colpi di baionetta e cadde da una
terrazza. Due commilitoni lo raccolsero in fin di vita ed Enrico Guastalla lo
portò sulle sue braccia. Fu curato all’ospedale dei Fatebenefratelli, diretto
dalla giornalista americana Margaret Fuller Ossoli. Una volta guarito, fu
nominato sottotenente e rimase qualche tempo a Roma. Grazie alla
protezione del conte Giulio Litta, riuscì a tornare a Milano e negli anni che
seguirono espose a Brera alcune opere di tema risorgimentale che ricordavano gli
eventi che lo avevano visto protagonista a Roma, come "La difesa del Vascello",
"Porta San Pancrazio dopo l’assedio del 1849" o "Trasteverina colpita da una
bomba".
e
stanze. Durante quell’operazione, in cui perse la vita Giacomo Venezian,
Gerolamo Induno fu gravemente ferito da 27 colpi di baionetta e cadde da una
terrazza. Due commilitoni lo raccolsero in fin di vita ed Enrico Guastalla lo
portò sulle sue braccia. Fu curato all’ospedale dei Fatebenefratelli, diretto
dalla giornalista americana Margaret Fuller Ossoli. Una volta guarito, fu
nominato sottotenente e rimase qualche tempo a Roma. Grazie alla
protezione del conte Giulio Litta, riuscì a tornare a Milano e negli anni che
seguirono espose a Brera alcune opere di tema risorgimentale che ricordavano gli
eventi che lo avevano visto protagonista a Roma, come "La difesa del Vascello",
"Porta San Pancrazio dopo l’assedio del 1849" o "Trasteverina colpita da una
bomba".
Dal 1854 al 1855
aveva partecipato alla campagna di Crimea, militando nel corpo dei bersaglieri
di Alessandro La Marmora in qualità di pittore-soldato ed eseguendo disegni,
studi e resoconti per immagini. Al ritorno in patria quegli schizzi diventarono
quadri pieni di sentimenti patriottici, molto apprezzati dalla critica. Tra
questi, "La battaglia di Cernaia", che gli era stata commissionata dallo stesso
Vittorio Emanuele II.
Nel 1855 ottenne un
grande successo all’Esposizione Universale di Parigi. In seguito espose alcuni
dipinti di vario tipo, dalla veduta al ritratto, sia a Milano che a Firenze.
Nel 1859 si arruolò
come ufficiale garibaldino dei Cacciatori delle Alpi, continuando a dipingere e
a prediligere i temi patriottici e confermandosi come il principale interprete
dell’epopea risorgimentale. Alle rappresentazioni di tono aulico, come "La
battaglia di Magenta", alternò soggetti più intimi o di genere: "Un grande
sacrificio" (l’addio della madre del garibaldino), "La partenza del coscritto",
"Triste presentimento". Famoso fu "L
a
battaglia della Cernaia", acquistato da Vittorio Emanuele II. Molto apprezzati
anche il "Legionario garibaldino alla difesa di Roma" o "Episodio dell’assedio
di Roma del 1849", forse realizzato alcuni anni dopo.
 Il
5 maggio del 1860 Garibaldi salpava da Quarto per la Sicilia. Anche se Induno,
dopo tante battaglie, non era fisicamente tra i Mille, partecipò idealmente
all’impresa traducendo in pittura le cronache dei giornali e i racconti dei
reduci. In un’atmosfera velata dal rimpianto, anche l’arte storica o celebrativa
si apriva al sentimento, come ne "L’imbarco dei Mille a Quarto", dove
l’attenzione si sofferma sugli episodi del garibaldino che bacia il figlio o
della moglie che piange per la partenza del marito.
Il
5 maggio del 1860 Garibaldi salpava da Quarto per la Sicilia. Anche se Induno,
dopo tante battaglie, non era fisicamente tra i Mille, partecipò idealmente
all’impresa traducendo in pittura le cronache dei giornali e i racconti dei
reduci. In un’atmosfera velata dal rimpianto, anche l’arte storica o celebrativa
si apriva al sentimento, come ne "L’imbarco dei Mille a Quarto", dove
l’attenzione si sofferma sugli episodi del garibaldino che bacia il figlio o
della moglie che piange per la partenza del marito.
Negli anni Sessanta
dell’Ottocento era ancora impegnato in dipinti celebrativi, da "L’ingresso di
Vittorio Emanuele II a Venezia" a "La morte di Enrico Cairoli a Villa Glori", ma
prese parte anche a grandi imprese decorative, come le Allegorie di Firenze e di
Roma e nella rinnovata stazione Ferroviaria di Milano o il sipario del teatro di
Gallarate. Intanto la sua arte subiva un’evoluzione verso una pittura dalla
pennellata quasi virtuosistica e con soggetti di gusto neosettecentesco,
esemplificata da "La partita a scacchi" e "Un amatore di antichità".
Dopo una lunga
malattia, morì a Milano il 19 dicembre del 1890.