 Il
5 novembre 1924 veniva approvato il progetto d’isolamento dell’area
dei Fori Imperiali, il cuore vivo e pulsante della Roma antica, ma
anche un centro nevralgico di quella moderna, denso di abitazioni e
monumenti. Dopo alcuni scavi archeologici, nel 1930 Corrado Ricci,
che rivestiva la carica di direttore generale delle Antichità e
Belle Arti del Governatorato, diede il via alle demolizioni
nell’area dei Fori di Traiano, di Augusto, di Nerva, della Basilica
di Massenzio, per realizzare quella che si sarebbe chiamata via
dell’Impero e che avrebbe congiunto piazza Venezia al Colosseo. I
lavori, gli sbancamenti, ma anche la distruzione di tante memorie di
un passato più o meno remoto sono oggi documentati ai Musei
Capitolini fino al 20 settembre nella mostra "Via dell’Impero.
Nascita di una strada", promossa dall’Assessorato alle Politiche
Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma, Sovraintendenza
ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.
Il
5 novembre 1924 veniva approvato il progetto d’isolamento dell’area
dei Fori Imperiali, il cuore vivo e pulsante della Roma antica, ma
anche un centro nevralgico di quella moderna, denso di abitazioni e
monumenti. Dopo alcuni scavi archeologici, nel 1930 Corrado Ricci,
che rivestiva la carica di direttore generale delle Antichità e
Belle Arti del Governatorato, diede il via alle demolizioni
nell’area dei Fori di Traiano, di Augusto, di Nerva, della Basilica
di Massenzio, per realizzare quella che si sarebbe chiamata via
dell’Impero e che avrebbe congiunto piazza Venezia al Colosseo. I
lavori, gli sbancamenti, ma anche la distruzione di tante memorie di
un passato più o meno remoto sono oggi documentati ai Musei
Capitolini fino al 20 settembre nella mostra "Via dell’Impero.
Nascita di una strada", promossa dall’Assessorato alle Politiche
Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma, Sovraintendenza
ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.
Sono sessanta le foto scattate da
fotografi professionisti romani come Filippo Reale, Michele
Valentino Calderisi e Cesare Faraglia, che il rapido e intenso
procedere degli abbattimenti e degli sterri. Le foto sono affiancate
da alcuni dipinti commissionati dallo stesso Governatorato a
Maria Barosso, Lucia Hoffmann, Giulio Farnese, Odoardo Ferretti,
Vito Lombardi e altri, per conservare la memoria di tutto ciò
che andava scomparendo. A corredo della mostra sono st ati
anche selezionati alcuni significativi reperti di età romana,
rinvenuti durante l’incalzante ritmo dei lavori, che portarono al
recupero e al ripristino scenografico delle antichità romane con
l’intento di rafforzare simbolicamente la continuità di Roma
fascista con l’Impero Romano. Tra le scoperte più importanti, i
resti di una domus rinvenuti nel giardino di villa Rivaldi. "Da
questa domus, che aveva già restituito in passato alcune
sculture oggi conservate per lo più ai Musei Vaticani – precisa
Claudio Parisi Presicce, dirigente dei musei archeologici e d’arte
antica del comune di Roma - proviene la maggior parte delle
sculture a tutto tondo rinvenute nell’area e conservate nei Musei
Capitolini, parte in Campidoglio e parte alla Centrale Montemartini.
In tutto furono raccolte più di cinquanta opere tra statue, teste,
rilievi e frammenti, e la loro edizione parziale fu affidata subito
dopo lo scavo a Domenico Mustilli".
ati
anche selezionati alcuni significativi reperti di età romana,
rinvenuti durante l’incalzante ritmo dei lavori, che portarono al
recupero e al ripristino scenografico delle antichità romane con
l’intento di rafforzare simbolicamente la continuità di Roma
fascista con l’Impero Romano. Tra le scoperte più importanti, i
resti di una domus rinvenuti nel giardino di villa Rivaldi. "Da
questa domus, che aveva già restituito in passato alcune
sculture oggi conservate per lo più ai Musei Vaticani – precisa
Claudio Parisi Presicce, dirigente dei musei archeologici e d’arte
antica del comune di Roma - proviene la maggior parte delle
sculture a tutto tondo rinvenute nell’area e conservate nei Musei
Capitolini, parte in Campidoglio e parte alla Centrale Montemartini.
In tutto furono raccolte più di cinquanta opere tra statue, teste,
rilievi e frammenti, e la loro edizione parziale fu affidata subito
dopo lo scavo a Domenico Mustilli".
Un panorama ricco, quello offerto
dalla mostra, che illustra la successione degli interventi, da
Piazza Venezia e dal quartiere Alessandrino fino allo sbancamento
della collina della Velia. Una sezione è anche dedicata al restauro
e al ripristino dei colonnati del tempio di Venere a Roma che
fiancheggia la parte terminale della strada verso il Colosseo.
"L’idea geniale di congiungere piazza
Venezia con il Colosseo e con la via del Mare, per mezzo di due
ampie strade, possibilmente tracciate secondo la linea più breve,
non fu ispirata soltanto da ragioni estetiche,ma anche specialmente
da ragioni pratiche", spiegava Antonio Muñoz nel 1932 dalle pagine
della rivista Capitolium. "Una comunicazione diretta – continuava -
tra il centro e i quartieri del Celio dell’Esquilino e del Laterano
mancava finora, perché la maggiore arteria, la via Cavour, andava a
morire contro la barriera del Foro Romano, e si perdeva in un dedalo
di viuzze. Che insieme con questa necessità di ordine pratico,
l’opportunità di aprire la nuova strada sia stata confermata da alte
finalità di carattere estetico ed archeologico, è un caso veramente
fortuito".
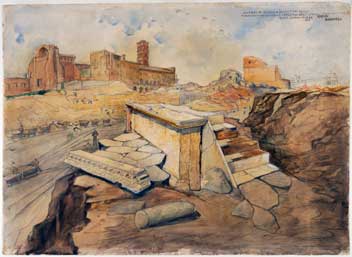 Nella
città moderna voluta da Mussolini non ci sarebbe stato spazio per
"quei vecchi labirinti di vicoli senza marciapiede, dove rumoreggia
la vita popolare", "si doveva bandire - avverte Maria Elisa Tittoni,
dirigente dei musei d’arte medioevale e moderna del comune di Roma -
quel colore locale dei vecchi pittoreschi rioni, che da sempre aveva
caratterizzato lo spazio urbano. La creazione di quella che verrà
chiamata via dell’Impero coniugò ragioni estetiche e motivi pratici:
si voleva connettere rapidamente, con una strada adatta al traffico
automobilistico, piazza Venezia con il Colosseo, il Celio,
l’Esquilino e il Laterano in previsione dell’espansione della città
verso i Castelli".
Nella
città moderna voluta da Mussolini non ci sarebbe stato spazio per
"quei vecchi labirinti di vicoli senza marciapiede, dove rumoreggia
la vita popolare", "si doveva bandire - avverte Maria Elisa Tittoni,
dirigente dei musei d’arte medioevale e moderna del comune di Roma -
quel colore locale dei vecchi pittoreschi rioni, che da sempre aveva
caratterizzato lo spazio urbano. La creazione di quella che verrà
chiamata via dell’Impero coniugò ragioni estetiche e motivi pratici:
si voleva connettere rapidamente, con una strada adatta al traffico
automobilistico, piazza Venezia con il Colosseo, il Celio,
l’Esquilino e il Laterano in previsione dell’espansione della città
verso i Castelli".
Completa il percorso espositivo una
serie di grafici, realizzati o commissionati dallo stesso Muñoz, che
illustrano i progetti per l’assesto definitivo della strada e la
sistemazione dei muri di contenimento della Velia, insieme ai
disegni delle carte geografiche che raffigurano i domini dell’antica
Roma, ancora oggi visibili sul muro sottostante la Basilica di
Massenzio.
 Il
5 novembre 1924 veniva approvato il progetto d’isolamento dell’area
dei Fori Imperiali, il cuore vivo e pulsante della Roma antica, ma
anche un centro nevralgico di quella moderna, denso di abitazioni e
monumenti. Dopo alcuni scavi archeologici, nel 1930 Corrado Ricci,
che rivestiva la carica di direttore generale delle Antichità e
Belle Arti del Governatorato, diede il via alle demolizioni
nell’area dei Fori di Traiano, di Augusto, di Nerva, della Basilica
di Massenzio, per realizzare quella che si sarebbe chiamata via
dell’Impero e che avrebbe congiunto piazza Venezia al Colosseo. I
lavori, gli sbancamenti, ma anche la distruzione di tante memorie di
un passato più o meno remoto sono oggi documentati ai Musei
Capitolini fino al 20 settembre nella mostra "Via dell’Impero.
Nascita di una strada", promossa dall’Assessorato alle Politiche
Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma, Sovraintendenza
ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.
Il
5 novembre 1924 veniva approvato il progetto d’isolamento dell’area
dei Fori Imperiali, il cuore vivo e pulsante della Roma antica, ma
anche un centro nevralgico di quella moderna, denso di abitazioni e
monumenti. Dopo alcuni scavi archeologici, nel 1930 Corrado Ricci,
che rivestiva la carica di direttore generale delle Antichità e
Belle Arti del Governatorato, diede il via alle demolizioni
nell’area dei Fori di Traiano, di Augusto, di Nerva, della Basilica
di Massenzio, per realizzare quella che si sarebbe chiamata via
dell’Impero e che avrebbe congiunto piazza Venezia al Colosseo. I
lavori, gli sbancamenti, ma anche la distruzione di tante memorie di
un passato più o meno remoto sono oggi documentati ai Musei
Capitolini fino al 20 settembre nella mostra "Via dell’Impero.
Nascita di una strada", promossa dall’Assessorato alle Politiche
Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma, Sovraintendenza
ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura. ati
anche selezionati alcuni significativi reperti di età romana,
rinvenuti durante l’incalzante ritmo dei lavori, che portarono al
recupero e al ripristino scenografico delle antichità romane con
l’intento di rafforzare simbolicamente la continuità di Roma
fascista con l’Impero Romano. Tra le scoperte più importanti, i
resti di una domus rinvenuti nel giardino di villa Rivaldi. "Da
questa domus, che aveva già restituito in passato alcune
sculture oggi conservate per lo più ai Musei Vaticani – precisa
Claudio Parisi Presicce, dirigente dei musei archeologici e d’arte
antica del comune di Roma - proviene la maggior parte delle
sculture a tutto tondo rinvenute nell’area e conservate nei Musei
Capitolini, parte in Campidoglio e parte alla Centrale Montemartini.
In tutto furono raccolte più di cinquanta opere tra statue, teste,
rilievi e frammenti, e la loro edizione parziale fu affidata subito
dopo lo scavo a Domenico Mustilli".
ati
anche selezionati alcuni significativi reperti di età romana,
rinvenuti durante l’incalzante ritmo dei lavori, che portarono al
recupero e al ripristino scenografico delle antichità romane con
l’intento di rafforzare simbolicamente la continuità di Roma
fascista con l’Impero Romano. Tra le scoperte più importanti, i
resti di una domus rinvenuti nel giardino di villa Rivaldi. "Da
questa domus, che aveva già restituito in passato alcune
sculture oggi conservate per lo più ai Musei Vaticani – precisa
Claudio Parisi Presicce, dirigente dei musei archeologici e d’arte
antica del comune di Roma - proviene la maggior parte delle
sculture a tutto tondo rinvenute nell’area e conservate nei Musei
Capitolini, parte in Campidoglio e parte alla Centrale Montemartini.
In tutto furono raccolte più di cinquanta opere tra statue, teste,
rilievi e frammenti, e la loro edizione parziale fu affidata subito
dopo lo scavo a Domenico Mustilli".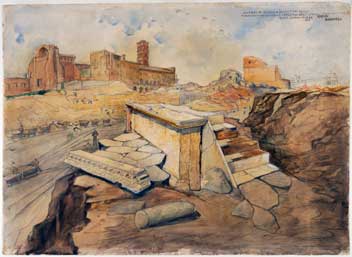 Nella
città moderna voluta da Mussolini non ci sarebbe stato spazio per
"quei vecchi labirinti di vicoli senza marciapiede, dove rumoreggia
la vita popolare", "si doveva bandire - avverte Maria Elisa Tittoni,
dirigente dei musei d’arte medioevale e moderna del comune di Roma -
quel colore locale dei vecchi pittoreschi rioni, che da sempre aveva
caratterizzato lo spazio urbano. La creazione di quella che verrà
chiamata via dell’Impero coniugò ragioni estetiche e motivi pratici:
si voleva connettere rapidamente, con una strada adatta al traffico
automobilistico, piazza Venezia con il Colosseo, il Celio,
l’Esquilino e il Laterano in previsione dell’espansione della città
verso i Castelli".
Nella
città moderna voluta da Mussolini non ci sarebbe stato spazio per
"quei vecchi labirinti di vicoli senza marciapiede, dove rumoreggia
la vita popolare", "si doveva bandire - avverte Maria Elisa Tittoni,
dirigente dei musei d’arte medioevale e moderna del comune di Roma -
quel colore locale dei vecchi pittoreschi rioni, che da sempre aveva
caratterizzato lo spazio urbano. La creazione di quella che verrà
chiamata via dell’Impero coniugò ragioni estetiche e motivi pratici:
si voleva connettere rapidamente, con una strada adatta al traffico
automobilistico, piazza Venezia con il Colosseo, il Celio,
l’Esquilino e il Laterano in previsione dell’espansione della città
verso i Castelli".